il mio primo Apple
Avevo un amico, un ex compagno di classe dei giorni del Liceo, che vendeva computer. Sto parlando della prima metà degli anni ottanta, quando vendere computer non era una occupazione normale. Era più una media fra vendere elettrodomestici e razzi per andare sulla luna. Avevo già avuto un incontro ravvicinato con un computer qualche anno prima, all’Università, mettendo le mani su di un Tektronic sepolto negli scantinati dell’Istituto di Neurofisiologia (lo stesso dove avrebbe preso vita la teoria dei neuroni a specchio). Era stato amore a prima vista, e come per ogni amore, non saprei spiegare il perché. L’idea di comunicare con un cervello elettronico tramite una tastiera era carica di fascino. Forse era stato l’imprinting di Hal 9000, il computer del film Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, o di Mother, in Alien di Ridley Scott.
Un neurologo americano mi aveva insegnato i rudimenti del BASIC, e io passavo le ore serali (le uniche in cui mi era concesso libero accesso al computer) a sperimentare brevi listati. Già quella era un’operazione da thriller: dovevo entrare nell’istituto deserto, accendere le luci al neon e scendere le scale per raggiungere gli scantinati, che erano anche gli stabulari, per sedere di fronte alla macchina. L’abilità consisteva nel realizzare un listato con il numero minore possibile di linee di codice. Nei primi computer lo spazio era un lusso. Il mio contributo fu di ridurre il codice per disegnare le assi cartesiane X e Y dei grafici, utilizzando un loop.
Un giorno di qualche anno dopo, l’amico del negozio di computer mi mostrò un Apple Lisa appena arrivato. Muovendo il mouse era possibile spostare un cursore sullo schermo, con cui assemblare il disegno di una motocicletta, per esempio trasportando l’immagine della marmitta. Avevo chiesto: “A cosa serve?”, una domanda che in futuro mi sarei a mia volta sentito rivolgere spesso, e che non avrebbe mancato mai di irritarmi. Ma con il senno di poi, riconosco che quella domanda riassumesse niente meno che il Sacro Graal del marketing dei Personal Computer: per quale motivo qualcuno avrebbe dovuto investire più di un sudato stipendio per portarsi a casa un computer? Era quella la risposta che un’azienda informatica avrebbe dovuto saper offrire al cliente.
Vale la pena di ricordare che Apple Italia nasceva in quei giorni, il gennaio del 1984. Dal 1979 (l’anno di arrivo di Apple II Europlus) al 1983, gli Apple II erano stati importati, con successo, da un’azienda di Reggio Emilia, la IRET.
Finalmente laureato, con il primo stipendio di ufficiale medico mi presentai all’amico venditore con l’intenzione di acquistare un Commodore 64, che in quei giorni era il più popolare fra i microcomputer economici. Proprio perché era a buon mercato, i primi nerd lo usavano per giocare collegandolo alla TV. Il mio progetto non era però quello di usarlo per i videogame, ma di programmarlo, e di trasferirci i miei archivi cartacei. E magari di usarlo anche come macchina per scrivere, al posto dell’Olivetti elettrica su cui battevo i pezzi per il Mucchio Selvaggio.
L’amico mi mostrò effettivamente un Commodore, ma per sottolineare quanto fosse limitato per la realizzazione dei miei progetti. Il suo business principale era nei PC IBM per gli uffici, e nei primi PC compatibili. Perciò gli capitava di ritirare computer Apple, che era stata l’azienda leader del mercato ma ora soffriva della concorrenza di Big Blue. Così mi vendette un Apple //c: un computer bellissimo, con 128 kilobyte di ram ed un floppy disk integrato. Tutti i computer di Apple avevano una linea da arte moderna, ma il “2 C” era addirittura bellissimo. Aveva un’aspetto vagamente androide, quasi come il suo fratello maggiore, il Macintosh.
Il Mac aveva ereditato l’interfaccia grafica del Lisa, ma il suo prezzo era proibitivo, specie se non sapevi cosa farci. La livrea bianca del //c faceva parte di uno stile di design che prendeva il nome di Snow White (in italiano Biancaneve). Ricordo il profumo di plastica nuova surriscaldata che diffondeva nella stanza quando lo accendevi. Assieme al computer era arrivata una quantità di software con cui sbizzarrirsi. AppleWorks, un programma integrato con cui scrivere ed archiviare, ma soprattutto sperimentare il foglio di calcolo, le cui possibilità erano stimolanti.
Fra gli altri, un gioco di avventura testuale, intitolato Avventura nel Castello. Il computer ti raccontava una storia (mentre sorvolavi la Scozia il tuo aereo andava in panne e precipitava, costringendoti a paracadutarti nel cortile di un castello disabitato) e tu potevi muoverti battendo dei comandi sulla tastiera, del tipo “apri la porta” o “mangia il gatto” ed ottenere una risposta. Era un’interazione con un mondo virtuale, una sorta di intelligenza artificiale.
L’Apple //c arrivava con due grossi manuali sull’AppleSoft BASIC (allora tutti i computer avevano un linguaggio di programmazione in memoria, tipicamente per l’appunto un Basic) e fu un piacere studiarli nei dettagli per imparare a istruire il computer. Ti faceva sentire una sorta di Creatore di un mondo personale. Era una sensazione inebriante, ma i segreti da imparare erano molti di più di quelli che riuscivi ad acquisire. Ogni mese aspettavo con impazienza il nuovo numero di Applicando, che era la rivista ufficiale di noi utenti italiani. In ogni numero, Applicando proponeva pagine di listati di programmi di varia utilità, che si potevano copiare battendoli sulla tastiera. Tipicamente in quei giorni chi acquistava un computer cercava anche di programmarlo, a meno che non si trattasse dell’IBM dell’ufficio. Sugli scaffali delle librerie i libri di informatica erano pochi, ma di ottima qualità. Fu un’emozione trovarmi di fronte ad un libriccino intitolato più o meno “Scrivere un’avventura”, dello stesso autore dell’Avventura nel Castello, vale a dire Enrico Colombini, un personaggio leggendario di quegli anni ruggenti. Mi misi al lavoro con entusiasmo, e ispirato al film In Compagnia dei Lupi di Neil Jordan, grazie al listato che Colombini metteva generosamente a disposizione, riuscii a scrivere la mia avventura, “di Cappuccetto Rosso”. Già che c’ero, ero riuscito ad infilarci in ruoli cameo anche Pinocchio, il Gatto e la Volpe, i tre porcellini.
Erano gli anni prima del web e della posta elettronica: mi capitò di leggere su una rivista (Super Apple) che Colombini era di Brescia, e consultando l’elenco telefonico di quella città mi procurai il suo numero. Lo chiamai e fu così gentile da darmi un appuntamento, e divenni suo amico - per quello che ci si possa dichiarare amico di un personaggio così geniale ed al tempo stesso riservato. Era un generoso: in futuro mi avrebbe aiutato innumerevoli volte, sia a realizzare una versione grafica della mia avventura per il Macintosh, che per scrivere e pubblicare i miei futuri articoli e libri. Una volta hackerò per me un programma allo scopo di salvare il mio disco rigido (l’hard disk arrivava con un software per gestirlo, ma quando si “corruppe” - allora accadeva con una certa frequenza - il programma non lo riconosceva più e si rifiutava di formattarlo: in questo modo funziona la mente degli ingegneri. Colombini riuscì a bypassare quel controllo usando il linguaggio macchina, una magia che gli vidi eseguire sotto i miei occhi).
Oltre che di Apple II, Applicando scriveva sempre più spesso di un computer incredibilmente innovativo dall’interfaccia grafica color della carta: il Macintosh. Leggevo e rileggevo ogni parola di quegli articoli, cercando di immaginare come sarebbe stato lavorare in ambiente grafico, usando il mouse ed i menu. Una volta di più devo ringraziare l’amico negoziante. Mi mise in contatto con un gioielliere che aveva bisogno di un programma per stampare le etichette con gli indirizzi dei regali di Natale da inviare ai suoi clienti. Usai a questo scopo AppleWorks e gli vendetti l’intero pacchetto, computer e software (quando penso che quel banalissimo compito oggi sarebbe difficoltoso da eseguire, mi domando in che direzione sia andata l’informatica).
Con il ricavato fui in grado di pagarmi un Fat Mac, cioè un Macintosh con 512 Kb di memoria RAM ed un innovativo floppy disk di plastica da 3” ½ (invece di quello di carta da 5 pollici dell’Apple II e degli altri computer del momento - da cui il nome floppy, cioè flessibile). Presto mi riuscì persino di barattarlo con un Macintosh Plus.
Lavorare con l’interfaccia grafica del Mac era una cosa così sorprendente da sognarmelo di notte. Innanzi tutto il Mac aveva un tenero aspetto da E.T. Il suo schermo integrato, anziché nero con caratteri verdi come i computer dell’epoca, era bianco come la carta, e muovendo il mouse spostavi sullo schermo un cursore a freccia, nella metafora di una scrivania di lavoro, con tanto di cartelle e di documenti. Con un click del pulsante del mouse selezionavi il documento, con un doppio click lo aprivi. Tenendo premuto il tasto mentre spostavi il mouse, spostavi il documento, magari per trascinarlo in una cartella, nel cestino o su un secondo dischetto. Poteva trattarsi di un documento di testo o di un’immagine di MacPaint (un’immagine composta di puntini, i pixel) o di MacDraw (un’immagine vettoriale di figure geometriche).
Il Macintosh era addirittura trasportabile, utilizzando il bellissimo borsone che veniva mostrato nella pubblicità. A dispetto del peso, il Mac lo trasportavo davvero, per scrivere le mie cose usando MacWrite. Ovviamente andava collegato ad una presa di corrente. MacWrite era un programma spartano: ogni 250 caratteri andava a capo, che tu avessi terminato o meno il paragrafo. Forse anche la lunghezza del documento era limitata. Il primo programma di scrittura professionale ad arrivare sul mercato fu Microsoft Word 3.0 (la versione 2.0 non era mai uscita), che era potente e persino elegante. Fu un’eccezione, perché da quel momento in avanti tutti i programmi di Microsoft per Mac e per MS-DOS (il sistema operativo dei PC IBM compatibili) sarebbero stati un po’ pacchiani, zeppi com’erano di comandi e di menu...
leggi tutto su Il futuro non è mai come te lo saresti aspettato
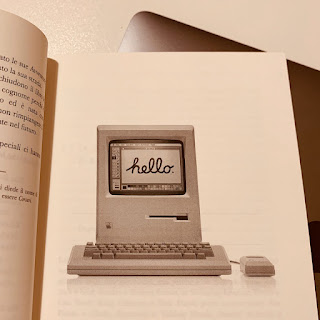


Commenti
Posta un commento